Tredici.
Se c'è una cosa
che ricordo spesso dei miei primi giorni trascorsi su Marte è quella afferente
la nostra incapacità di trovare un accordo sul da farsi. Eppure eravamo stati
addestrati, benché in poco tempo, a fare cerchio e a trovare la quadra per
tutte quelle problematiche che si potevano riscontrare una volta giunti sul
Pianeta rosso. Se poi ci aggiungevamo il nostro dolore per la perdita dei nostri
giovani compagni di avventura, allora il problema si amplificava e lasciava
poco spazio a qualunque margine di manovra e di trattativa fra di noi. Le nostre
differenze culturali, fisiche, e quant'altro, ci avevano portati, in più di una
circostanza, ad ignorarci; ciò era dovuto al fatto che preferivamo restare in
silenzio e a isolarci dalla nostra realtà quotidiana, per dimenticare il nostro
triste vissuto. Johannés preferiva allenarsi, raccogliere i frutti che ci
donavano le colture idroponiche, scrivere il suo libro sulla nostra
"disavventura", piuttosto che parlare con me e con Red; Red si
dedicava anima e corpo alla sua ordinaria attività lavorativa, dedicandoci solo
un po' del suo tempo prezioso ogni qualvolta fosse stato costretto a convincerci che
era necessario che noi tutti ci sottoponessimo a quegli esami di laboratorio
cosiddetti di routine, per la successiva analisi dei nostri parametri vitali.
Io, per quanto mi riguarda, ricordo di essermi isolato dagli altri due
astronauti per più di un anno: avevo i miei buoni motivi, d'altronde. Mi ero
dedicato alla realizzazione del mio progetto, ovvero quello di costruire un
robot in grado di smantellare la nostra navetta spaziale, recuperare i
materiali e la tecnologia necessaria per la costruzione di un rover elettrico
che ci consentisse di andare via, definitivamente, dal cunicolo lavico in cui
nell'ultimo anno avevamo trovato ospitalità. Montavo, smontavo, collegavo,
scollegavo, e poi rimontavo nuovamente centinaia di migliaia di volte la mia
creatura che, nei primi giorni di vita, non voleva fare il suo dovere sino in
fondo, facendomi disperare per la mia incapacità di realizzare qualcosa che
funzionasse a dovere e che potesse consentirci di sloggiare da quel posto che
ormai ci andava strettissimo. Un giorno pensai che la mia creatura non volesse
funzionare a dovere solo perché ancora non gli avevo dato un nome; forse avevo
ragione, forse no. Sta di fatto che solo dopo che lo battezzai
"Teddy" il robot prese vita, riuscendo a relazionarsi sia con me che
con gli altri due sopravvissuti. "Teddy fai questo", "Teddy fai
come ti dico" e Teddy rispondeva ad ogni mio comando, alla velocità della
luce. Teddy un giorno mi disse che fosse al nostro servizio per consentirci di
sopravvivere ed io, sebbene consapevole che parlassi con una macchina, lo
ringraziai calorosamente. Teddy impiegò meno di due mesi a smontare la navetta
spaziale, a costruire una sorta di fonderia, a testare ogni qualsiasi voglia
apparecchiatura elettronica che fosse idonea alla realizzazione della
"quatto ruote" marziana a bordo della quale noi tre, un giorno,
avremmo potuto lasciare quell'anfratto di roccia lavica che ci aveva ospitati
sino a quel momento. Non lo sapevo ancora, ma Teddy, oltre ad essere il robot
costruttore, era anche la prima cellula di quella IA che oggi governa Marte. Spero,
un giorno, che il mio nome possa essere annoverato sui libri di scuola, ancorché
digitali, come l'ingegnere che, inconsapevolmente, fu l'inventore dell'Intelligenza Artificiale che oggi domina gli umani e le cose presenti su
questo desolato corpo celeste.










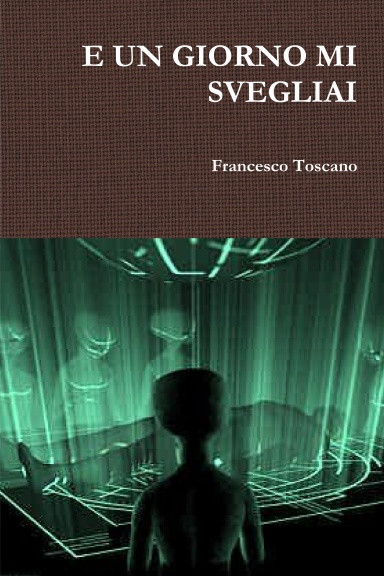

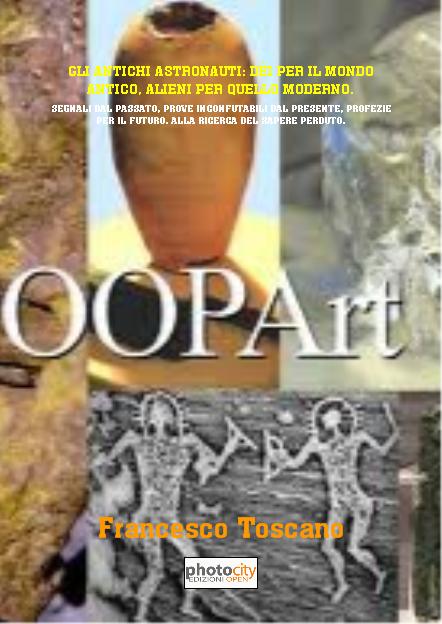
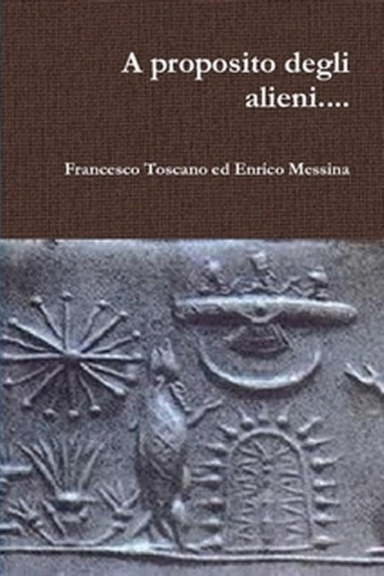



0 comments:
Posta un commento