Prima Edizione.
Giugno 2013.
.
Uno.
Di quel dì in cui la mia vita e il mio destino cambiarono per sempre, ricordo solo che era un uggioso pomeriggio di fine febbraio, uno dei mesi più freddi nella provincia di Palermo, l'area geografica di questo piccolo globo in cui, sono nato, cresciuto, e più volte mi sono reincarnato. L'aria intrisa d'umidità, spinta da delle folate di un freddo vento di maestrale, entrava in maniera irruente nelle nostre ossa, poveri mortali, costringendoci a stringerci nei nostri scialli di lana di concia, a volte puzzolenti, sino quasi ad asfissiarci, e a imbacuccarci nei nostri paltò di panno robusto che coprivano i nostri pantaloni di fustagno che denotavano le misere condizioni socio economiche in cui eravamo costretti a vivere. Nulla di strano se ciò fosse avvenuto in un altro posto al mondo. Era molto strano per noi siciliani che, oltre a soggiacere alle intemperie, fossimo ancora costretti a marcire nella nostra miseria, nonostante l'Italia fosse stata creata e il governo monarchico ci avesse garantito, a più riprese, che da lì a qualche anno la nostra vita sarebbe migliorata. Purtroppo non avevamo fatto i conti con la "crisi di fine secolo", un periodo di recessione economica che contribuì, infatti, all'aumento della tensione sociale e politica, che si tradusse nella successione di undici governi nei dieci anni che seguirono. Correva l'anno 1893 e il primo governo Giolitti era già in parlamento da circa nove mesi, e lì vi sarebbe rimasto in carica, se non ricordo male, sino al mese di dicembre di quell'anno, per un totale di cinquecento settantanove giorni. Non so dirvi che cosa mi accadde quel giorno nefasto, e mai sarò in grado di spiegarlo ad alcuno, sebbene me l'abbiano chiesto in tanti in questi ultimi due secoli di oscurità. Non credevo, prima di passar "a miglior vita", quando ancora mi trovavo sulla Terra, che l'Inferno esistesse, sebbene la mia cultura, e la religione da me professata sino a qualche anno prima che io morissi, mi avessero insegnato tutto il contrario. Quello era un Inferno più dantesco che cristiano, più allegorico che metafisico. La mia anima, pur tuttavia, allontanandosi in vita dalla Luce, così precipitando nel buio degli abissi tenebrosi, aveva avuto modo di conoscere e di sperimentare ciò che significasse, per davvero, vivere nella tristezza più assoluta, nell'estremo dolore, nell'enorme disperazione e tormento eterno. Facevo mille supposizioni del perché fosse successo proprio a me, alla mia anima, nel reincarnarmi in quelle nuove vite, chiedendomi ogni istante che cosa avessi potuto realizzare se fosse andata diversamente; per quale motivo la mia anima aveva fatto le stesse esperienze delle vite precedenti, così costringendomi a rimanere in quest'universo fatto di sofferenze e di malvagità?
«La Giuria!»
Tutte le anime che affollavano l'assemblea si alzarono dalle poltrone in cui sedevano, inchinandosi in direzione della Suprema Corte.
«Che l'imputato si alzi!» disse il giudice a latere che sedeva a fianco del Presidente della Corte.
Non obiettai. Mi alzai in piedi pronto ad accettare la Sentenza di condanna che da lì a poco sarebbe stata emessa nei confronti della mia anima, forse per l'eternità.
«Che cosa ha da dichiarare a sua discolpa?» disse il Presidente della Corte, guardandomi quasi volesse procedere a un'introspezione psicologica.
«Nulla vossignoria!» dissi timidamente. «Ammetto le mie colpe e chiedo la clemenza della Corte…», dando così sfogo, ed esternando, tutti i sentimenti di contrizione che in quegli ultimi anni avevo man mano concepito.
«Allora ammettete i fatti che vi vengono contestati? Vi dichiarate colpevole di aver trucidato la vostra famiglia, in un momento d'ira sfociato in un raptus omicida?»
«Sì!»
«Orbene, a conclusione di questi cento anni d'investigazioni, tenuto conto delle circostanze attenuanti ammesse, e in virtù dei poteri a me conferiti», disse il Presidente della Corte, «condanno quest'anima a espiare duecento anni di pena sul pianeta Terra, reincarnandosi per ben tre volte in una nuova vita.» Continuando disse: «quest'anima avrà cura di condurre queste altre tre vite nella preghiera e nella penitenza, al fine di lenire il dolore arrecato ad altre anime, le quali nel corso di questo processo hanno chiesto a questa Corte, in ragione dei sentimenti d'amore che vi legarono in vita, di esser assai clemente nel formulare questa Sentenza di condanna appena emessa nei vostri confronti.»
Non dissi nulla. Non replicai. Accettai di reincarnarmi per altre tre volte in una nuova vita sul mio pianeta d'origine. Ero consapevole del fatto che la mia anima mi avrebbe costretto a vivere nel pentimento, Ad maiorem Dei gloriam, di luterana memoria.
Prima di uscire dalla sala dell'assemblea, il Presidente disse: «Accompagnate quest'anima nella sala dell'oblio, affinché si possa reincarnare in una nuova vita.»
E ancora, rivolgendosi direttamente al mio spirito: «Ricordati che ti restano solo queste tre possibilità di redenzione, e che se dovessi fallire miseramente la prova di virtù che ti è stata assegnata, ti ritroverai a dover lottare con le fiere, i prossimi tuoi simili.»
Girai lo sguardo verso i miei due carcerieri che mi stavano per accompagnare nella sala dell'oblio quando, a un tratto, mi balenò in mente un ricordo di una vita da me già trascorsa, sintetizzabile in questa massima ricca di saggezza: «Chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso.»
Mi feci coraggio, lasciandomi trascinare in quella nuova realtà e dimensione dell'essere.
Venerdì, 4 maggio 1990. In una modesta casa del quartiere Ballarò di Palermo.
(Un neonato piange disperato per la fame.)
«Non piangere piccolo mio, che la tua mamma ora ti canterà questa bellissima canzone: Apri i miei occhi Signore… Apri i miei occhi Signore.. Voglio vederti, voglio vederti….. Apri i miei occhi Signore… Apri i miei occhi Signore….Voglio vederti, voglio vederti.. Vederti splendere su me… Nella luce della Tua gloria.. Versa il Tuo amore su noi.. Mentre cantiamo "Santo Santo"…Santo, Santo, Santo.. Voglio vederti! Santo, Santo, Santo..Santo, Santo, Santo…Voglio vederti! »
«Comare Piera, chi ci avi ù picciriddu?» disse la zia Tina, urlando con voce febbrile dal basso accanto.
«Zia Tina, zia Tina, presto, presto, entrate! Non riesco a far quietare la mia creatura.»
«Puvirazzu! Ha le coliche addominali...» precisò la zia Costantina, alle donne del quartiere meglio nota come à zì Tina. Era una piccola donna, ormai prossima a compiere sessantacinque anni, che in gioventù si era prostituita perché costrettavi dal marito, che si premurava ora, in età avanzata, a compiere quelle opere di bene che la vita dissoluta, che aveva condotto, sino a un ventennio addietro, non le aveva fatto ultimare, tenuto anche conto che era ormai prossima a morire, e che avrebbe fatto di tutto per salvare la sua anima da una sicura dannazione eterna; almeno così le disse, un giorno, Fra Rosario, un fraticello della chiesa di San Domenico, all'uscita dalla messa vespertina.
«Il dottore mi ha prescritto delle gocce da dargli, macché.. nulla!» disse Piera, con le lacrime che le rigavano il viso, mossa da quell'istinto materno che le avrebbero fatto fare di tutto per alleviare le sofferenze alla sua prole. E in preda ad una crisi di nervi, continuò dicendo:
«Sono le 20.00 e quel debosciato di suo padre ancora non è rientrato. Che ve ne pare, Zì Tina? Il bambino ha bisogno di cure, d'amore, e lui che fa, va girando taverne, taverne, ogni giorno sempre più ubriaco fradicio!»
La zia Tina, mossa a compassione, le disse: «Non ti preoccupare figlia mia, non disperare che le cose si aggiustano. Tutto sommato è un brav'uomo, timorato di Dio, che arranca a trovare un lavoro; è per questo, secondo me, che sfocia nei fumi dell'alcol la sua rabbia, proprio perché non può dare a suo figlio una vita più dignitosa e agiata.»
Mentre l'anziana donna parlava, tessendo le lodi del giovane compagno di comare Piera, dalla strada una voce mesta e grave attirò la loro attenzione:
«Piera! Piera! Dove sei maledetta femmina, dannazione dell'anima mia?»
Piera non rispose, timorosa di nuove ritorsioni di quel manesco di Turiddu, che sovente aveva risolto le controversie domestiche con botte e calci, lasciandosi trasportare dai fumi dell'alcol e sfociando la sua rabbia repressa nei confronti della sua giovane moglie, la cui unica colpa era stata di proferire quel fatidico "sì", quel giorno di San Cosma e Damiano sull'altare della Chiesa della Martorana, (o di Santa Maria dell'Ammiraglio, o San Nicolò dei Greci), alla fine del mese di settembre di un quinquennio prima. Di quel giorno Piera ricordava con affetto, fra l'altro, le grida festose dei pescatori e dei marinai che festeggiavano i loro Santi patroni, Cosimo e Damiano, un tempo venerati in maniera fastosa in alcune borgate della città di Palermo, poiché la tradizione popolare riteneva che i Santi, essendo fratelli, forse gemelli e, ambedue medici, avessero il potere di guarire affezioni e malanni d'ogni tipo.
L'anta di destra della porta che chiudeva il basso si aprì, facendo scorgere nella penombra la sagoma corpulenta di Turiddu che, malgrado avesse da poco compiuto trentacinque anni, sembrava fosse prossimo a compierne cinquanta di anni. Turiddu entrò all'interno della modesta e umile stanza da letto, che fungeva anche da soggiorno, cucina, salotto, annessa alla quale un piccolo bagno, malandato, dagli scarichi del quale esalavano, durante i mesi estivi, odori nauseabondi e fetidi. Piera istintivamente strinse al suo petto il piccolo Marco, nome di battesimo che aveva dato al nascituro in ricordo del defunto padre di Turiddu, vittima di lupara bianca, cercandolo di proteggere dalla violenza e dalle percosse che il suo uomo era solito somministrarle.
«Che si mangia in questa casa d'inferno?» disse Turiddu, arcuando il sopracciglio destro, del suo volto raffazzonato e trasandato, e ammorbando l'aria con il suo alito vinoso.
La donna rispose, piangendo:
«Che si mangia? Che si mangia? Veleno si mangia! Ogni santo giorno, ormai da circa due anni. Ma che ho fatto di male nella mia vita per meritarmi un marito del genere? Ah? Che ho fatto di male? Non fai nulla per meritarci. Non fai nulla per donarci un po' d'amore. Guardati! Mi fai schifo!»
A quest'insulto Turiddu rispose con la violenza, non curante che Marco avesse cominciato a piangere ancora di più, impaurito delle urla dei suoi genitori, togliendosi la cintura in cuoio dai pantaloni che calzava e brandendola dalla fibbia, con la mano destra, dopo aver sollevato il braccio destro in aria, sferrò un colpo all'indirizzo di Piera che solo per miracolo non le sfigurò il volto.
Tanta violenza non poteva che sortire l'intervento delle comari e dei compari viciniori di basso, che arrivarono, addirittura, a minacciarlo che se non l'avesse finita avrebbero chiamato gli sbirri.
«Curnutu ru diavulu, calmati! Calmati!» gli disse zù Momo che era giunto in casa per sedare gli animi e soccorrere la figlioccia Piera, il cui padre gliel'aveva affidata qualche anno prima in punto di morte.
«Ma che minchia stai combinando?» aggiunse Momo. Dopo l'intervento dello zù Momo gli animi si quietarono, e tornò il silenzio nel vicolo, la cosiddetta "quiete dopo la tempesta".
Piera non aveva dormito quella notte; si era girata e rigirata più volte fra le lenzuola di quel letto matrimoniale che era costretta a condividere con quell'infimo uomo di Turiddu Scarpinato, come se fosse una cotoletta impanata; quando erano da poche scoccate le ore 06.00, si era da poco appisolata. Si alzò di scatto sentendo piangere il suo bambino. Lo prese in braccio, cullandolo amorevolmente. Il bambino smise di piangere solo dopo che la donna se lo portò al seno per allattarlo. Mentre stava allattando il suo bambino, guardò la sua immagine riflessa nello specchio del comò della stanza da letto. Solo allora si rese conto di aver perso quei tratti di giovinezza che sino a poco tempo prima l'avevano contraddistinta fra le donne del quartiere.
Aveva da poco compiuto ventisette anni. Piera era alta un metro e settanta, corporatura normale, carnagione chiara; di lei, la figlia di Carlo il fornaio, morto in un incidente stradale quando aveva da poco compiuto quarant'anni, lasciandola sola al mondo, le persone che l'avevano conosciuta ricordavano il volto tondeggiante, le guance rosse tempestate da due fossette ammalianti, e quegli occhi neri e luccicanti che, quando ti guardavano, ti scrutavano dentro, sino a svelare i più nascosti segreti dell'animo umano.
Si voltò a guardare quell'uomo che aveva tentato di picchiarla la sera precedente, che dormiva al suo fianco, muovendosi con cautela, timorosa del fatto che potesse svegliarlo e mandarlo in escandescenza, come una bestia che, essendo costretta a starsene in gabbia, e privata di quel fondamentale dono che la natura ci ha elargito e che molti esseri viventi inseguono, che da sempre noi esseri umani chiamiamo libertà, alla prima occasione reagisce a quella coercizione fisica con irruenza.
Ed era proprio la libertà che aveva perso, poveretta, quella dei tempi migliori, quando il suo amato padre, la domenica, la portava a mangiare un gelato a porta di Termini, facendola sentire la cosa più importante al mondo.
Più volte, in quegli ultimi due anni, cioè dal giorno in cui Turiddu aveva perso il lavoro da muratore presso una ditta edile con sede legale in provincia di Palermo, aveva metabolizzato l'idea che fosse giunto il momento di lasciarlo, di mandarlo a farsi fottere, di rispedirlo a quella famiglia di merda cui apparteneva e della quale aveva ereditato tutti i lati negativi del suo carattere.
Poi si ricredeva, ritornando sui suoi passi, sostenendo che quell'uomo che dormiva al suo fianco, di notte, non fosse lo stesso uomo che aveva sposato, del quale, un tempo, era perdutamente innamorata.
Tre.
«Perché non mi ha condannato per l'eternità?» dissi ai miei carcerieri mentre mi conducevano verso la stanza dell'oblio, luogo in cui aveva sede la macchina della metempsicosi, programmata non solo per far rispettare la decisione adottata dalla Suprema Corte all'atto del verdetto finale, ma anche per scegliere, fra tutti i luoghi dell'Universo, e fra tutti gli esseri viventi che lo popolano, in quale nuova creatura l'anima del condannato si sarebbe dovuta reincarnare e presso quale luogo, secondo schemi e concetti che esulano l'umana comprensione.
Uno dei due carcerieri, quello che mi teneva i ceppi che mi attanagliavano i polsi dalla mia parte destra, mi disse:
«Che cosa pretendevi? Forse speravi di farla franca e di non patire le pene dell'Inferno?»
E l'altro, incuriosito dalla mia reazione alla condanna da poco inflittami, mi disse:
«Non sottovalutare la possibilità di redenzione che ti è stata concessa. L'anima non è fatta per soffrire, ma per ricongiungersi con il Dio Creatore dell'Universo, verso cui desidera recarsi, una volta e per sempre…» precisandomi poco dopo:
«Le concezioni primitive intorno all'anima sono concordi nel considerare questa come indipendente nella sua esistenza dal corpo. Dopo la morte, sia che l'anima seguiti a esistere per sé senza alcun corpo o sia che entri di nuovo in un altro corpo di uomo o d'animale o di pianta e perfino di una sostanza inorganica, seguirà sempre il volere di Dio; cioè il volere dell'Eterno di far sì che le anime da lui generate e create possano trascendere la vita materiale e innalzarsi a un piano più alto dell'esistenza, imparando, pian piano, a comprendere il divino e tutto ciò che a lui è riconducibile.
Le antiche religioni e filosofie hanno costruito teorie capaci di spiegare da una parte la costituzione fisica dell'uomo e la sua origine e, dall'altra, la sua costituzione morale e la sua sorte. A questo secondo scopo ha servito la dottrina della metempsicosi, la teoria secondo la quale l'anima dopo la morte passa di continuo da un corpo all'altro, finché non si sia resa del tutto indipendente e libera dalla materia.
Il bene e il male operato in una vita viene ricompensato, a volte, automaticamente, per intima connessione causale, con la reincarnazione nella vita successiva in un corpo, a seconda del merito, superiore o inferiore, durante un corso indefinito di esistenze, dal quale solo si può uscire per mezzo della conoscenza della natura labile di tutte le cose.»
Entrai all'interno del marchingegno della metempsicosi, divenendo in un istante un insieme di matrice di punti che occupava, nello stesso momento, lo spazio-tempo senza alcuna distinzione fra il presente, il passato ed il futuro; tutto era noto, tutto era scritto, nulla era lasciato al fato. Pochi secondi dopo inalai il mio primo respiro, respirando a pieni polmoni, nel corpo del neonato che tutti, qualche giorno dopo, chiamarono Turi, Turiddu di mamma, Turiddu ru me cori.
Quattro.
Palermo, lunedì 27 febbraio 1893, ore 22.00.
Quartiere dell'Albergheria.
L'oscurità in cui versano le strade di Palermo non poteva non favorire anche il mal costume, fomentato soprattutto dall'eterno bisogno. Dove l'oscurità era più fitta, qui, vi si raccoglievano male femmine, delle quali era una vera falange. Nel rione dell'Albergheria esse infestavano luoghi reconditi, attiratevi specialmente dalla vicinanza dei quartieri militari. Il vicolo degli Zingari, presso Porta di Castro, parla ancora. In tutta la città però queste sacerdotesse di Venere si raccoglievano all'ombra delle conniventi pinnati, cioè delle tettoia o gronda sporgente dai muri degli edifici e delle case nelle vie, numerosissime anche dopo la provvida pulizia che ne fece, Pretore il Regalmici, la Deputazione delle strade[1], e per vecchio costume riconducibili a quei posti del Cassaro che agevolavano le fermate e ne proteggevano le clientele; onde il titolo di cassariote[2]. In altre vie di Palermo durante il dì, di secondo, di terz'ordine, stanno di casa e di bottega, artigiani, che dalla specialità dei loro mestieri prendono nome le vie: Materassai, Sediari, Formari, Pianellari, Spadari, Cintorinai, Tornieri, Gallinai. A brevi distanze singolare è il contrasto di vita e di movimento. Silenziosi i vicoli dei Calzonai, dei Frangiai e dei Mezzani, che pur danno sul Cassaro; stridenti quelli degli Schioppettieri, dei Chiavettieri (magnani), e dei Cassari, che intronano le orecchie.
Erano da poco scoccate le 22.00 quando un uomo, dall'apparente età di anni quaranta, alto circa un metro e settantadue, corporatura esile, capelli neri e folti, occhi piccoli e racchiusi fra due lenti da miope, ingobbito nel suo paltò robusto e scuro, si dirigeva con passo barcollante verso la via dei Chiavettieri, presso la Vicaria.
Qui, al civico venti, da circa due generazioni la sua famiglia aveva una piccola bottega dalla quale traeva il suo sostentamento economico.
Camminando, camminando, recitava la sua preghiera al suo santo protettore:
«Si vô' junciri sanu, Nun ti scurdari lu patrinnostru a Sanciulianu. Sanciulianu, 'ntra l'äuti munti, guarda li passi, e pöi li cunti: Tu chi guardasti l'acqua e la via, guardami a mia e a la mè cumpagnia.»
Badate bene, quell'uomo non aveva paura dell'oscurità, né delle bande di malavitosi che infestavano i rioni della sua amata Palermo, ma di quella strana premonizione che lo aveva assalito già dalle prime ore del giorno, forse evocata dalla sua anima; da lì a poco, infatti, egli avrebbe compiuto un gesto insano, di quello che macchiano l'anima umana per l'eternità.
Si era diretto nuovamente verso la sua bottega, che aveva badato a chiudere verso le ore 20.00, dopo una dura giornata lavorativa, di quelle che ti sfiancano sino al collasso, proveniente da una taverna posta a breve distanza dove aveva scambiato due chiacchiere con gli amici davanti un vinello bianco il cui sapore difficilmente avrebbe dimenticato, e accortosi che si era fatto una certa ora, desideroso di rientrare nella sua casetta, povera ma pulita, e dignitosa, si accingeva ad aprire la porta di casa con una delle chiavi che aveva personalmente fabbricato, quando a un tratto udì provenire dall'interno di casa dei rumori molesti.
Entrò di soppiatto, mantenendo il respiro come se si fosse immerso in apnea nel mare blu che tanto amava, pensando di cogliere in fallo il ladro malcapitato, quando scorse sua moglie, disgraziata maledetta, a letto con un tale, più giovane di lui di circa vent'anni, nella classica posizione del missionario che godeva come una troia mentre quel bastardo la stava penetrando, a pochi centimetri dalla culla in cui dormiva il suo primogenito, nato qualche anno prima da quel matrimonio che gli sembrava che fosse la cosa più bella che la vita gli avesse offerto da quando aveva emesso il suo primo e forte vagito. Alla vista di quella scena, che mai aveva pensato potessero vedere i suoi occhi, il sangue gli salì nel cervello offuscandogli la vista già precaria; prelevò dalla tasca destra dei pantaloni un coltello a serramanico, lo aprì, e con una violenza inaudita colpì i due amanti, tante e tante volte, così facendo schizzare il loro sangue ovunque, imbrattando anche la culla in cui dormiva il suo angelo. Pochi secondi d'ira, che lo portarono a quell'omicidio. Poco dopo, non contento di quell'orrore, infilzò più volte la sua creatura la cui unica colpa era stata quella di dormire al fianco di quella stronza di una donna che aveva ordito il tradimento fra le mura del focolare domestico. Riprese coscienza qualche minuto più tardi.
Legò con cura una corda nel soffitto. Salì sulla prima sedia che videro i suoi occhi e, dopo aver fatto passare la corda nell’architrave in legno di abete del tetto, si annodò al collo un cappio. Diede un colpo secco alla sedia su cui era salito con il piede destro; il peso del suo corpo permise alla corda di spostare in alto e indietro l'osso ioide e la base della lingua, causando l'asfissia che lo condusse alla morte. Pochi secondi dopo, quel disgraziato penzolava dal soffitto come un salame affumicato. Sulla sua tomba qualche buontempone scrisse: «Qui giace Domenico Calandrei, per gli amici Mimì, che in un momento d'ira, trucidò moglie, amante, figlio, e poi si tolse la vita per impiccamento.»
Cinque.
Un forte mal di testa attanagliava le meningi di cumpari Turiddu quando, finalmente, si alzò dal letto matrimoniale. Di Piera e del bambino nessuna traccia. Nessun segno visibile a occhio nudo faceva trapelare che lei avesse scelto volontariamente di andarsene di casa, lasciandolo lì da solo come un verme. Che cosa le era passato per la mente a quella pazza? Chi cazzo si credeva di essere quella stronza maledetta che era stata la rovina della sua casa?
«Puttana impertinente!»
Continuò ancora per qualche minuto in tal guisa, come se non avesse alcuna colpa di quello che era successo la sera precedente, colpa che era da imputare, nella sua mente, solo ed esclusivamente a quella stronza di sua moglie, quando si accorse che sotto il lume poggiato sul marmo del comò della stanza da letto, vi era una lettera manoscritta, in cui Piera aveva annotato le testuali parole:
«Aspetto, aspetto e sono sempre botte, non so neanche più chi sono, né ho cognizione di che cosa debba fare. Tutte le volte mi dico che è l'ultima volta, ma poi non faccio nulla, se non aspettare che tu ritorni a casa. Ogni giorno è uguale, sempre con la paura di sbagliare e forse sbaglio. Non voglio che capiti qualcosa di brutto né a me, né a nostro figlio. Sono proprio stanca, e ho tanta paura. Tu mi controlli sempre, mi assilli, mi togli la vita. Ti auguro tutto il bene di questo mondo. Non ci cercare più!»
«Ma sì, che se ne vadano pure! Io posso continuare a vivere senza di loro. Sono loro che hanno bisogno di me!» Si recò in bagno. Puzzava da far schifo. Si abbassò la patta dei pantaloni che indossava dalla sera precedente, sgualciti e luridi, e tirò fuori il suo pene.
Pisciò come non aveva fatto mai prima di allora.
«Ah! Una pisciata liberatoria! Quello che ci voleva….. Buongiorno!»
Aprì il rubinetto della doccia e aspettò invano, e per qualche minuto, che scendesse l'acqua calda. Non ricordava che la società elettrica, che gli aveva sino a poco tempo prima fornito l'energia elettrica, gli aveva scollegato l'impianto elettrico dalla rete elettrica principale, per morosità. Non si era mai chiesto, nei mesi precedenti, quando la sera si ritirava a casa, il perché quei sedici metri quadrati di casa, ordinata solo perché Piera odiava il disordine e la sciatteria, erano illuminati dalla luce fioca delle candele.
Resosi conto che l'acqua calda non sarebbe mai e poi mai scesa dalla doccia, si convinse che forse era meglio lavarsi con l'acqua fredda.
«Arrusa ra miseria, puttana! Ma cu minchia mu fici fari, Dio…» Bestemmiò, bestemmiò a squarciagola, come se quelle offese rivolte al Creatore potessero, d'un tratto, stravolgergli la vita.
«Sta troia si purtò ù picciriddu! E ora chi fazzu?»
Si rese conto, solo allora, che l'unica speranza che aveva di non morire di fame era legato proprio al fatto che avesse una famiglia, anzi, per meglio dire, una moglie rompi coglioni ed un figlio scassa minchia, che non faceva altro che piangere tutto il giorno, i quali gli potevano garantire quel sussidio familiare che lo Stato da qualche tempo gli devolveva, per la loro precaria situazione economica, anche se i soldi erano pochi e non bastavano neanche a farsi un goccetto di quel buon vino che la taverna di Mario di via Porta di Castro custodiva nelle botti di acacia, ideale per la custodia di quel vinello, una bevanda che tanto aveva gradito negli ultimi anni.
Il dottore Maffei glielo aveva detto però: «Stia attento Salvo, che si sta rovinando la vita; l'alcol la sta allontanando dalla realtà che la circonda.»
Gli ultimi esami clinici, del resto, testimoniavano il suo pessimo stato psicofisico, dovuto al suo stato d'alcolista.
Solo allora si ricordò quello che il dottor Maffei, con studio medico chirurgico in via Antonio Mongitore, all'angolo con via Orlando Diego, gli disse un giorno, mentre Piera, piangendo, lo pregava di cambiare condotta e stile di vita: «Salvo, dal punto di vista medico l'alcolismo si distingue in acuto e cronico. Nell'alcolismo acuto l'intossicazione è caratterizzata da un graduale passaggio dall'effetto piacevole ed euforizzante della bevanda alcolica (allegria, socievolezza) sino alla comparsa di un'alterazione motoria e ideativa che può giungere anche allo stato di coma alcolico, stadio che può condurre al collasso e alla morte, oppure può risolversi con il ritorno alla normalità. Una fase intermedia fra alcolismo acuto e alcolismo cronico è rappresentata dalla cosiddetta ubriachezza patologica, rilevabile soltanto in soggetti con caratteristiche psicopatiche costituzionali; si tratta, in genere, di individui che hanno una personalità abnorme, relativamente instabile, o sono portatori di piccole lesioni organiche del sistema nervoso centrale che abitualmente rimangono silenti e che vengono rivelate da stimoli nocivi di origine esterna..»
Lui, da ignorante qual era, non capì che cosa il medico gli volesse dire; non aveva fatto attenzione alle sue parole, sbadigliando per tutto il tempo, da perfetto maleducato, come se fosse uno scolaretto impenitente. Una cosa ricordava: Piera piangeva, piangeva disperata a quelle ultime parole che il dottor Maffei aveva finito di proferire.
Ebbe i rimorsi di coscienza.
Si sbarbò, si mise quello che restava del dopobarba regalatole da Piera molto tempo addietro, si vesti e usci di casa alla ricerca di sua moglie e di suo figlio. Varcato l'uscio della porta d'ingresso della sua abitazione sembrava che fosse un altro uomo rispetto a quello che la sera prima, nella penombra, si era intrufolato nella vita di Piera e di Marco, mettendo a repentaglio il loro stato di salute.
Fuori la loro piccola dimora, la prima cosa che gli balenò in mente fu quella di andare a bussare alla porta di zì Tina.
«Zì Tina, zi Tina, rapitimi à puorta!»
«Cù è che scassa i cabassisi ri prima matina?» rispose l'anziana donna, alzandosi dal letto, ancora con la bocca impastata e gli occhi appiccicosi, che faceva fatica ad aprire. Anche a lei piaceva fare le ore piccole, retaggio di quel passato che ormai non le apparteneva più, dormendo sino a tardi la mattina, qualora ne avesse avuto voglia.
«Sugnu io, Turiddu! Ca vistu a Piera?»
La zì Tina gli rispose che Piera non l'aveva vista dalla sera precedente, chiedendogli, di contro, se fosse successo qualcosa e se Marco, l'angioletto che reggeva in piedi quella famiglia sgangherata, stesse bene.
«No, niente! Tutto bene! Tutto bene…..solo che mi sembrava che Piera si fosse recata presso la sua abitazione sta matina. Mi scusassi, mi scusassi s'arrivigghiavu. Buongiorno! Sa benerica!» Zi Tina replicò dicendogli: «Ah talè! Attenta a mia! Se pocu pocu t'appermetti ri torcere un capiddu o picciriddu, ‘nca io vogghiu beni chiossà ra me vista, t'ammazzu come un crastu!»
Turiddu non rispose a quella provocazione, tenuto conto che ben conosceva l'indole di quella donna e di tutto il quartiere, qualora, putacaso, si fosse scontrato con lei, in quanto, benché fosse stata in passato una donna dai facili costumi, era ormai da circa vent'anni considerata da tutti gli abitanti dello storico mercato cittadino, una “santa donna”, che bisognava rispettare e venerare. Evitò di replicare. Si mise la coda fra le gambe e sgusciò via dal vicolo come un'anguilla impazzita.
Sei.
Turiddu si allontanò dal vicolo in cui abitava con il cuore in gola. Quella minaccia proferita da zì Tina lo aveva sconvolto. Che cosa voleva dire quella puttana? Che cosa sapeva? Che cosa le aveva raccontato Piera? Tali domande non potevano trovare risposta nell'immediato. Decise di allontanarsi il più velocemente possibile dal rione, convinto che lì non vi avrebbe trovato né la moglie, né suo figlio. Non che avesse paura di quella donna, sia bene inteso, ma dello zù Momo, l'amante di zì Tina, sì. Quell'uomo lo metteva in soggezione, sebbene fosse più basso di lui di parecchi centimetri, e fosse avanti negli anni. Non era il caso neanche di provarci a competere con quel "malacarne"; sicuramente avrebbe avuto la peggio, o direttamente o per vie traverse. Del resto lo zù Momo era, per quanto ne sapesse, il reggente dell'allora famiglia mafiosa di Ballarò/Porta Sant'Agata o Porta Nuova, la quale si era contraddistinta nel corso degli ultimi trent'anni per alcuni omicidi, e in diversi casi di lupara bianca di alcuni "uomini d'onore" affiliati ad altre famiglie mafiose dei quartieri limitrofi. Ricordava di aver sentito da alcuni picciotti, che frequentavano la taverna di Mario, a Porta di Castro, che lo zù Momo era arrivato ai ferri corti con alcuni di loro, in tempi non sospetti e negli anni di massimo splendore di "Cosa Nostra", per futili motivi legati al monopolio del traffico degli stupefacenti nel centro storico di Palermo. Si ricordò, solo allora, quanto pianse sua madre allorquando suo padre, lo zù Marco Scarpinato, "uomo d'onore", regolarmente "punciutu", nonché affiliato alla famiglia mafiosa di Porta Nuova, era scomparso per colpa della Mafia in auge nei primi anni Ottanta del Novecento. Si ricordò solo allora, andando con i ricordi indietro nel tempo, e spulciando nei cassetti della memoria, che il fatto era accaduto un giorno di fine agosto di otto anni addietro, mentre suo padre stava percorrendo lo stradone che da Monreale porta a Palermo, che il governo della città, nella seconda metà dell'Ottocento, aveva deciso di intitolare a Garibaldi e ai suoi mille garibaldini che erano giunti sino a Calatafimi. Chiamato originariamente lo "stradone" di Mezzo Monreale, prese il nome di corso Calatafimi dopo l'annessione della Sicilia al Regno d'Italia, in onore dell' "eroe dei due mondi", vincitore della battaglia di Calatafimi, che, dopo aver sconfitto le truppe borboniche a Pioppo, venne a Palermo proprio attraverso questa strada.
Sette.
Turiddu si ricordò che cosa gli disse sua madre, un giorno di fine agosto, mentre si trovavano in cucina a pelare le patate, e pochi giorni dopo la scomparsa di suo padre. A dire di sua madre, Nannarella Casamassima, all'epoca dei fatti una trentasettenne avvenente, rimasta vedova nel pieno della sua giovinezza, la scomparsa di suo padre era stata preceduta da un ignobile attacco di alcuni uomini facenti capo al gruppo di fuoco di Brancaccio che, in una tipica azione mafiosa, si erano caricati il suo amato marito in una macchina da loro poco prima rubata in viale Lazio, facendo poi perdere le loro tracce.
Questa confidenza, a sua madre, gliel’avevano fatta alcuni picciotti della famiglia mafiosa di Porta Nuova che, a loro dire, erano stati testimoni impotenti dell'evento delittuoso.
Si ricordò, inoltre, di quante lacrime egli avesse versato in seguito a quell'evento luttuoso, e di come si dovette prendere cura di sua madre, e degli altri suoi fratelli, essendo il figlio primogenito dell’ “uomo d’onore” ucciso, andando a lavorare come manovale in un cantiere edile di Bonagia, quartiere di Palermo ove l'allora speculazione edilizia aveva fatto sorgere dei casamenti di tipo residenziale che, a prima vista, sembravano tutti uguali.
«No, no, ma che cazzo sto pensando?» disse fra sé e sé.
Non voleva che certi pensieri fossero generati dalla sua mente. E in un momento di maggior lucidità mentale disse a se stesso: «Chisti se pocu pocu mi muovu malamente, mi fannu fare a fini ri me patri!»
Fece mille riflessioni ma, essendo fondamentalmente un codardo, in quanto aveva una paura fottuta di agire come avrebbe voluto (sebbene in tenera età, quando suo padre sparì dalla circolazione, avesse promesso a sua madre che un giorno gliel'avrebbe fatta pagare a quei bastardi che avevano rovinato la loro vita), decise di mettere un freno ai quei pensieri che il suo cervello, autonomamente, stava elaborando.
Continuò a camminare, e a guadarsi intorno, sperando di vedere Piera e il bambino. Stava percorrendo Corso Vittorio Emanuele quando, all'altezza di Piazza Bologni, incontrò “ù fimminedda”, un balordo di strada a cui i suoi amici avevano affibbiato tale appellativo, in virtù dei suoi più che discussi gusti sessuali.
«Fimminè, fimminè, non è che pi caso hai vistu a Piera e a mè figghiu?»
«Ciao Turì! No, non l'ho vista, picchì?»
«No, niente! A vaiu circannu picchì un mi ricuordo chi cosa mi rissi r'accattarici!»
«Minchia, Turì, pirdisti a memoria?»
«No, no, vabbè, scusa, ciao, ciao.»
«Ciao Turì. Puta casu a viru cuomo tu fazzu sapiri?» disse quella checca di fimminedda, credendo di fargli una cosa gradita.
«No, no, un ti preoccupare, ma chi viene a diri? Futtitinni! Mancu pi pigghiariti stu pinsieru! Ciao.»
Salutò l'amico con un bacio sulla guancia, che poi si pentì amaramente di averglielo elargito, e continuò per la sua strada. Aveva già percorso un centinaio di metri quando, ad un tratto, mentre ragionava fra sé e sé, incontrò lo zù Momo.
«Uè principali, come iamu?» disse lo zù Momo, per nulla sorpreso di incontrarlo, volendo prendere in giro.
«Sa benerica zù Momo! Scusassi se nun mi fiermu, ma vaiu ri prescia!»
«Pirchì? Chi c'è? C'è cuosa?»
«No, no, niente! Stavu circannu a mè mugghieri e o picciriddu, pirchì m'avia rittu ‘nca si truvava ri sti banni, pirchì c'avia accattari ù latti e autri cose a Marco, e io ci vulia rari na manu.»
Aveva mentito spudoratamente, perché aveva timore di qualche ritorsione dello zù Momo, tenuto anche conto delle minacce velate che la sera precedente, allorquando lo zù Momo si era recato presso la sua abitazione per sedare gli animi fra lui e sua moglie, gli aveva proferito alla presenza di sua moglie Piera.
In particolare, si ricordava che lo zù Momo gli aveva richiesto di marciare sul giusto binario, di stare in campana, e di non far soffrire la figlioccia Piera e il loro bambino. Che la doveva finire di bere, di mettersi la testa a posto e di cominciare seriamente a trovarsi un lavoro, precisandogli che "ù travagghiù" per i picciotti "assistimati" e “ra famigghia” non sarebbe mai mancato nei cantieri edili della zona, facendogli così intendere, chiaramente, che se avesse cambiato condotta e stile di vita, si sarebbe interessato in prima persona a cercargli un lavoro stabile.
Turiddu salutò lo zù Momo con un nodo in gola che facilmente avrebbe sciolto, qualora non avesse trovato sua moglie e suo figlio; le ritorsioni dello zù Momo nei suoi confronti, pensò, sarebbero stati maggiori se non si fosse riappacificato con la moglie e con il mondo intero.
Decise, allora, di continuare a cercare, speranzoso che prima o dopo avrebbe trovato sua moglie e suo figlio.
Otto.
Turiddu continuò a cercare sua moglie e suo figlio per le vie di Palermo per tutta la giornata, sino a tarda sera. Erano da poco scoccate le 21.00, quando metabolizzò l’idea che Piera ed il bambino potessero aver trovato rifugio dalla zia Sarina, zia materna di Piera, che abitava in un appartamento ubicato presso un condominio inserito nel contesto delle case popolari del quartiere Sperone di Palermo, nell'area sud-orientale della città.
Turiddu, avendo supposto che presso l’abitazione della zia Sarina avesse potuto rintracciare facilmente Piera ed il bambino, in considerazione dei buoni rapporti che intercorrevano fra sua moglie e la medesima zia Sarina, decise di dirigersi verso la Stazione Centrale, nei pressi di via Balsamo, luogo in cui era ubicato il capolinea dell’autobus di linea urbana numero 31, in servizio dalla Stazione Centrale di Palermo a via Giafar/Favier Prospero, per conto della società AMAT, l’azienda che gestiva in quel periodo il servizio pubblico in città, che gli avrebbe consentito, in pochi minuti, di raggiungere il quartiere dello Sperone. Gli venne in mente, tuttavia, che non aveva neanche una lira in tasca, e che non avrebbe potuto pagare neanche il biglietto per una corsa semplice, ma non se ne curò.
Turiddu pensò, infatti, che sarebbe potuto essere uno dei tanti utenti “portoghesi” che quotidianamente utilizzano gli autobus del servizio pubblico in funzione nella città di Palermo, senza pagare alcunché e prendendosi gioco, certe volte, di alcuni addetti al controllo.
«E s’acchiana ù cuntrulluri?», pensò preoccupato.
«Ma sì, minni futtu! Rapu a puorta ri rarrieri e scinnu! Chi cazzu mi può diri? Tantu unnè sbirru e un m’assicuta!»
Così fece.
Salì sull’autobus numero 31 che si trovava parcheggiato nei pressi del capolinea, a circa venti metri di via Paolo Balsamo; si sedette in uno dei sedili posteriori. Aspettò pochi minuti e l’autobus partì alla volta dello Sperone.
Lungo il tragitto che il bus urbano stava percorrendo per raggiungere lo Sperone, gli venne in mente che forse aveva esagerato con sua moglie. Lei era stata sempre un’ottima moglie, sempre amorevole nei suoi confronti, che non gli aveva mai fatto mancare nulla. Piera era, dopo sua madre, l’unica donna al mondo che l’avesse voluto bene.
«Sì! Ma unnè mè matri!»
Facendo questa considerazione, rifletté sul fatto che una donna, a lungo andare, si potesse stancare di un uomo come lui, che con il suo comportamento minava le fondamenta del rapporto di coppia, malgrado Piera, in tutti questi anni, gli avesse sempre dimostrato di amarlo incondizionatamente.
L’autobus su cui viaggiava, fra vari rollii e scossoni, dopo circa dieci minuti di tragitto, giunse finalmente in via Giuseppe Di Vittorio.
Turiddu suonò il campanello ubicato a pochi centimetri dell’anta di sinistra della bussola, per segnalare all’autista che sarebbe dovuto scendere alla fermata successiva e, all’apertura della medesima bussola, saltò fuori dal mezzo pubblico su cui aveva viaggiato gratuitamente.
Si trovò di fronte un casamento di cinque piani, in cemento armato, senza intonaco nel prospetto laterale sinistro e destro, e con il prospetto frontale e posteriore definito con dei mattoni in cotto, di colore rosso, che dividevano dei piccoli balconi aggettanti.
Turiddu notò che, in molte delle inferriate dei balconi dei vari appartamenti di quel fabbricato, ed esattamente nel prospetto frontale, gli abitanti del luogo avevano installato numerose antenne paraboliche che, secondo il suo giudizio critico, appesantivano ulteriormente l’architettura già carente e fatiscente di quello stabile.
Si avvicinò all’androne condominiale e suonò al citofono su cui era indicata la scritta “MONCADA Rosaria”. Nessuno rispose. Suonò nuovamente, ma nessuno rispose. Dopo cinque minuti di aver suonato con insistenza al citofono, un uomo gridò dal balcone del quarto piano:
«Où! Hai rotto il cazzo! A cù cierchi?» disse con aria minacciosa quell’ignoto individuo.
«Scusa, pensavo che non funzionasse! Pì casu c’è à zì Sarina, o Piera?»
«Cu minchia sunnu? Viri runni agghiri a faritilla ficcari ‘nto culu!»
Non replicò, timoroso della probabile ritorsione di quello e di tutti gli altri condomini di quello stabile decrepito; fece marcia indietro ed andò via, a piedi, continuandosi a girare e rigirare pensando che qualcuno fosse sceso giù per le scale di quel fabbricato e che lo stesse inseguendo.
Se ne ritornò a casa con lo stesso mezzo con cui era giunto allo Sperone.
Dopo essere rientrato a casa, esausto, si gettò sul letto matrimoniale, senza neanche spogliarsi e si addormentò, consapevole del fatto che il giorno successivo sarebbero riprese le ricerche di Piera e di suo figlio.
Prima di addormentarsi, da buon cristiano quale riteneva d’essere, recitò una preghiera, farfugliando qualcosa d’incomprensibile; si fece il segno della croce, chiedendo a Dio di perdonarlo per le sue malefatte, e, dopo aver chiuso gli occhi, sprofondò in un sonno lungo, profondo e restauratore.
Nove.
Erano trascorsi sei mesi dal giorno in cui Piera era andata via di casa unitamente al piccolo Marco.
Turiddu, benché li avesse cercati in lungo e in largo in diversi quartieri di Palermo, si rassegnò all’idea che, forse, non li avrebbe mai più rivisti.
Anche Turiddu aveva lasciato il quartiere Ballarò, e il vicolo, dove viveva con Piera e il loro bambino da sposato, per timore di ritorsioni da parte dello zù Momo e della sua amante, la zì Tina.
Per Turiddu era stato difficile accettare questa cruda realtà, ciò allontanarsi dal quartiere in cui era nato e cresciuto, e in cui vivevano sua madre e i suoi fratelli, per recarsi in un’altra località di Palermo, ma vi era stato costretto.
Aveva trovato un bilocale, di nuova costruzione, nei pressi dell’Acquasanta, a pochi metri dal locale porticciolo, che aveva preso in affitto a duecentocinquantamila lire il mese.
Pur non sapendo nuotare, non capiva come mai la sua anima fosse tanto attratta dal blu del mare, dal mare in tempesta, dalle onde spumeggianti. Pensò che forse in una vita precedente potesse aver avuto un rapporto diverso con il mare, questa vasta distesa di acqua salata convergente con i continenti e connessa con un oceano.
Pensò che forse, centinaia di anni prima, o migliaia di anni addietro, in una vita precedente, potesse essere stato un pescatore, o un maestro d’ascia, o un marinaio. Non lo sapeva con esattezza, ma qualcosa gli diceva che lui con quell’elemento, l’acqua marina, avesse avuto una connessione forte.
Si ricordò, solo allora, di quel sogno che fece da bambino, durante il quale aveva rivissuto gli attimi in cui era morto annegato, perché precipitato da un piroscafo e/o un bastimento che solcava l’oceano in direzione del “Nuovo Mondo”.
Turiddu si ricordò anche di come fosse rimasto traumatizzato da quel sogno e da quell’evento nefasto, e della risposta fornitagli da sua madre, la mattina seguente, quando glielo aveva raccontato. Nannarella, infatti, gli aveva detto:
«E se non fosse un sogno? Se tu quella scena l’avessi realmente vissuta? Figghiù mio la vita è un mistero! Pì mia i sogni sunnù i ricordi ra nostra anima. Nun ti scantari! È passato! Vieni qua, abbracciami!»
Dopo le minacce ricevute dallo zù Momo in seguito all’allontanamento volontario di Piera da Ballarò, Turiddu si era cercato un lavoro stabile e, soprattutto, aveva smesso di bere e di rovinarsi la vita.
Voleva cambiare, migliorare; non voleva che ripetesse tutti quegli errori del passato che gli erano costati l’affetto di Piera e del suo bambino. A questo repentino cambiamento di vita non c’era arrivato in poco tempo, ma solo dopo cinque mesi che Piera se ne era andata di casa, e grazie all'aiuto di Fra Diego, appartenente all'Ordine dei frati predicatori, sorto agli inizi del XIII secolo in Linguadoca a opera dello spagnolo Domenico di Guzmán con il fine di lottare contro la diffusione del catarismo, la più importante eresia medievale, il quale era solito dire messa, nei giorni feriali, nella Chiesa di Sant’Antonino, in corso Tukory.
Fra Diego si era affezionato a Turiddu, che negli ultimi mesi era divenuto un nuovo parrocchiano, trattandolo come un figlio, mosso a compassione dalla sua triste vicenda umana, e perché costrettovi dal giuramento prestato di alleviare le pene delle anime altrui.
Fu così che un giorno del mese di settembre del 1990, dopo la confessione di Turiddù, e finito di celebrare la messa, Fra Diego chiamò in disparte Turiddu e gli disse che era pronto ad aiutarlo, e che non si sarebbe dovuto preoccupare.
Qualche giorno dopo di buon’ora, infatti, Fra Diego si recò alla taverna di Mario, a Porta di Castro, ove era certo di incontrare Turiddu. Dopo che lo ebbe incontrato, gli disse di presentarsi il giorno successivo, alle ore 07.00, nel cantiere edile sito in via Ammiraglio Rizzo, all’angolo con la Salita Belmonte, nei pressi di Piazza Acquasanta, e che lì lo avrebbe atteso il geometra Vella, un suo amico d’infanzia, il quale gli avrebbe offerto un lavoro da manovale, a patto e condizione che non avesse più alzato il gomito, che non avesse più frequentato bettole e osterie, e che si fosse deciso, con tutto il suo cuore, di voler cambiare stile di vita.
Turiddu si mise a piangere, ringraziando dal profondo della sua anima il buon fraticello che il destino gli aveva messo sulla sua strada.
«Grazie parrì, nun vi scantati che nun vinni fazzu pentiri!»
Turiddu era al settimo cielo. Dal giorno seguente avrebbe ricominciato a vivere. Trascorse la notte a casa di un amico, cui aveva garantito un lauto compenso se lo avesse ospitato per quella notte e gli avesse garantito una doccia, una barba, e un paio di calzoni e una camicia puliti.
Quella notte recitò due ave Maria e un Padre Nostro, cosa che non aveva più fatto dalla Prima Comunione; si addormentò come un angioletto. Si risveglio alle 05.00 del mattino, al cantar del gallo, pronto per combattere nuovamente, consapevole del fatto che il destino gli avesse dato un’altra chance di salvezza, spirituale, psicofisica.
[1] Cfr. "La vita in Palermo cento e piu anni fa" di Giuseppe Pitrè. "Il dì 26 Maggio 1783 «la Deputazione delle strade, protetta dal Vicerè, mandava buon numero di manovali e di fabbri ferrai, i quali alla militare assaltarono contemporaneamente tutte le piazze di grascia della città ed altre contrade e vie nelle quali sono botteghe di venditori di annona, e riformano in guisa da contro le leggi civiche sporgono.
[2] Cfr. "La vita in Palermo cento e più anni fa" di Giuseppe Pitrè.
Punciuta è un termine in lingua siciliana che significa puntura e dà il nome al rito di iniziazione per i membri di Cosa nostra. L'iniziato viene condotto in una stanza alla presenza del rappresentante della famiglia e di altri semplici uomini d'onore. Uno dei momenti chiave, da cui la cerimonia prende il nome, è la puntura dell'indice della mano che l'iniziato utilizza per sparare con una spina di arancio amaro o, a seconda del clan mafioso, con un'apposita spilla d'oro. Il sangue fuoriuscito viene usato per imbrattare un'immaginetta sacra a cui in seguito viene dato fuoco mentre il nuovo affiliato la tiene tra le mani e pronuncia un giuramento solenne: "giuro di essere fedele a cosa nostra. Se dovessi tradire le mie carni devono bruciare come brucia questa immagine". Successivamente, vengono letti i cosiddetti "comandamenti" che dovranno essere rigorosamente rispettati.
Una famiglia, nel gergo della criminalità mafiosa, è un'organizzazione criminale, a capo delle quali vi è un capofamiglia, detto in lingua inglese boss. Questo tipo di aggregazioni criminali, composte da elementi criminali che hanno tra loro vincoli o rapporti di affinità, i quali si riconoscono in un capo e si danno una struttura gerarchica per riuscire a controllare tutti gli affari leciti e illeciti della zona dove operano. Sono tipiche di Cosa Nostra e delle sue ramificazioni negli Stati Uniti («Cosa Nostra americana»), dove mafiosi siciliani emigrati alla fine del XIX secolo si aggregarono pure in Famiglie e si diedero la stessa scala gerarchica che avevano in Sicilia. In tale ambito sono più specificamente chiamate cosche.








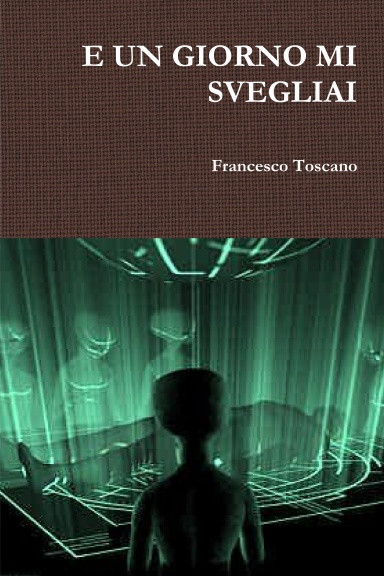

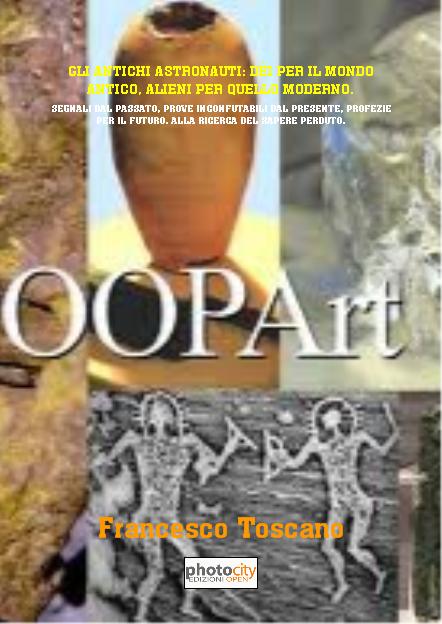
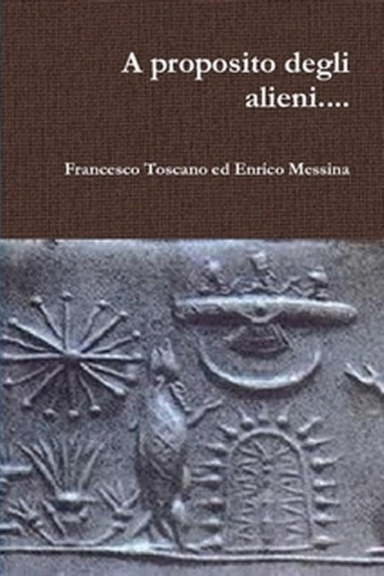



Egregio lettore, gentile lettrice del blog, buongiorno. Mi pregio di informarvi che è possibile acquistare il libro presso il portale statunitense http://www.lulu.com/shop/francesco-toscano/condannato-senza-possibilit%C3%A0-dappello/paperback/product-21162202.html al prezzo di € 10,00. E' possibile acquistare il libro in formato digitale, kindle edition, presso il portale http://www.amazon.it al prezzo di € 5,15.